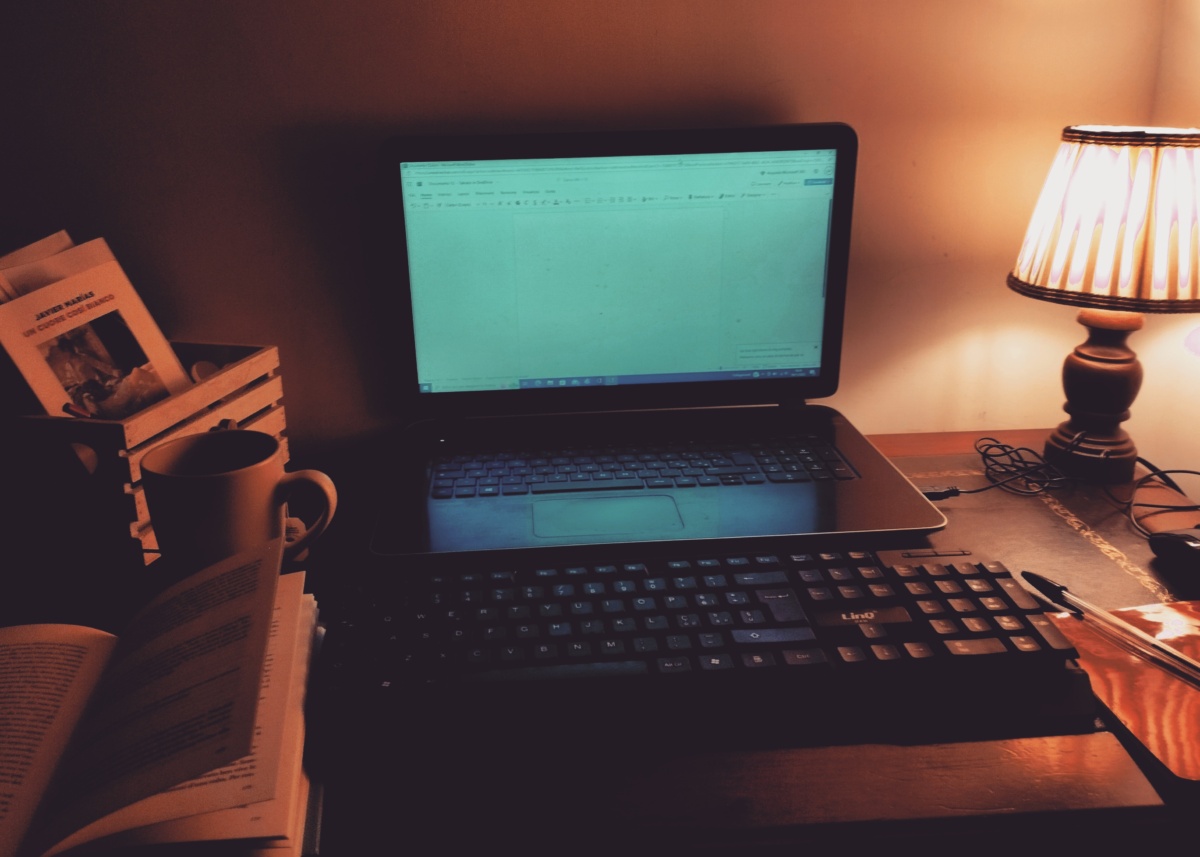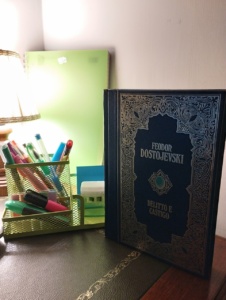Nella Battaglia domani pensa a me J.Marias "Nessuno pensa mai che potrebbe ritrovarsi con una morta tra le braccia e non rivedere più il viso di cui ricorda il nome". Il romanzo di Marias, Nella battaglia domani pensa a me, riecheggia di istantanee dialettiche come questa, incastonate in un dipinto di scene mitologiche, dove gli eroi sono i morti, e i vivi restano a contemplare le ultime luci delle loro scie. Questa non è infatti la storia di chi muore ma di chi sopravvive, con in mano i fili non ancora interrotti di quelle storie: perché la morte, nella sua subitanea irrimediabilità, è sempre, come dice lo scrittore madrileno, "inopportuna". Sarà perché ha a che fare con l'irreversibilità del tempo, con i contesti inaspettati oppure con i segreti che pungolano i vivi e li proiettano in vere e proprie indagini a ritroso, in quella che è una ricostruzione quasi archetipa dei giorni del morto. Cosa fare quando ci si trova tra le braccia un'amante appena s-conosciuta, che muore, prima ancora che il mondo a lei noto dei suoi affetti lo venga a scoprire? Marta Tellez è il nome della donna che gli spira tra le braccia e che lui, Victor, ha appena fatto in tempo a spogliare. Non sa molto altro di lei, se non quello che gli ha suggerito un reggiseno slacciato ma attaccato ancora al corpo come in una specie di adesione disperata all'ultimo istante di vita. Sa poi che ha un marito ora a Londra per affari, un bimbo di due anni, Eugenio, che dorme nella stanza a fianco, e sa quello che il nastro di una segreteria telefonica tradisce: l'esistenza di un altro amante che nelle sue ultime ore di vita la reclama, un paio di amici con i quali sarebbe avvenuta una cena da lì a qualche ora, un vecchio padre, il vecchio Tellez, che cerca sua figlia con un vago presentimento che appartiene solo ai vivi - e ai padri -, e su quel nastro c'è anche lui, proprio lui, Victor, lo sconosciuto di qualche giorno prima, che ora non è più sconosciuto, perché ora, pur non sapendo nulla di Marta Tellez, ha condiviso la cosa più assurda e intima a cui un individuo possa partecipare, la morte intima e tremendamente privata di un'amante appena incontrata. Ma a fare tenerezza, a suscitare pietà, non sono i morti, ed è questo il tema principale del romanzo; sono proprio i vivi che con il loro lutto, a volte clandestino, devono essere compianti nella loro incredulità dinanzi a quei fili non ancora interrotti: sono i fili estratti dalle macerie umane, le traiettorie tragiche che Victor ora attraversa in un estremo tentativo di far riposare i morti. Scuotono di malinconia i più fragili tra i vivi, i vecchi e i bambini. Perché in qualche modo né gli uni né gli altri si rassegnano alla morte o sanno riconoscerla: i primi, nella loro coriacea convinzione di essere destinati alla scomparsa per sempre mai dopo i loro figli, e i secondi, i bambini che scacciano il senso del mai più con l'innocente vento dei loro sogni. Diego De Silva e «Domani nella battaglia pensa a me» Tra i vecchi, il vecchio padre Tellez che seppellisce figli e una moglie senza soluzione di continuità; il Solo, un venerando ministro madrileno la cui solitudine si registra nella sua incapacità di scrivere da solo i propri discorsi pubblici; Enrico V di Shakespeare, che muore dannato nel tradimento degli affetti, citato nel titolo del romanzo e in quella trama che è il campo ordito dalla battaglia estrema, la battaglia della colpa, della solitudine e delle ombre. E poi ci sono loro, gli infanti, come il piccolo Eugenio che si addormenta nella stanza accanto, ignaro degli ultimi istanti della mamma Marta che di là, con il reggiseno ancora attaccato al cuore, chiude gli occhi per sempre; e il bambino che non può sapere, continua a guardar volare gli aeroplanini nel circuito aereo del suo lettino e chissà, chissà se vorrebbe vedere la mamma proprio lì, alla guida di un veicolo o semplice passeggera a ridosso delle ali sonore. I bambini e i vecchi alle prese con il dramma dei fili, le righe sottili e insostenibili delle cose appese, che ciondolano e tremano dinanzi ai vettori dei giorni che, incuranti di chi si è assentato per sempre, continuano a tuonare in molteplici direzioni, ad alimentare le vicende, a ricostruire i fatti senza più chi li ha fatti. Victor sente che tra le mani non gli è morta solo una donna, ma il senso stesso della vita che reclama spiegazioni. E si mette in moto per riannodare i fili interrotti degli altri e rimettere sui piedi le scene capovolte, i segreti di tutti, i silenzi che fanno da contrappeso alle morti assurde. Cosa deve rintracciare Victor? Deve aprire il sipario su quel mondo dei segreti che la segreteria telefonica ha appena tratteggiato: Edoardo, il marito assente, Vincent e sua moglie Ines, la strana coppia di amici di Marta, la famiglia di quest'ultima che come gitani tristi di un circo in disuso, continua a vivere in uno stato di "incantamento", che è quello stato, dice Marias, indotto dai fantasmi quando si dibattono per dissolversi, e invece, proprio loro tornano nei luoghi dove sono stati dei vivi: lì lasciano, appunto, dei fili e dei legami invisibili, che non sono altro che la condanna del loro ricordo. Marias è uno scrittore che non trascura mai, nei suoi romanzi che hanno tutti le sembianze di sequenze cinematografiche, il senso stesso della domanda incalzante e quasi materica: il gusto della retrospettiva, quei sussurri nelle orecchie o la ricorrente scena degli abbracci che arrivano alle spalle, le camminate sulle nuche degli amanti, tutto a dire dell'assenza dello sguardo del testimone che arriva sempre nel buio, nella non visibilità dei segreti; Victor è un testimone, quello vicario dell'ultimo sguardo sui morti e quello responsabile della vita dei vivi. Così Victor è diventato anche lui un filo, costretto a riannodarsi con quello degli altri che restano per tessere la trama del vivo: grazie all'amico Ruiberriz de Torres, trova lavoro presso il vecchio Juan Tellez, padre di Marta, che è il dipendente di un alto funzionario ministeriale denominato " il Solo". In questo modo riesce ad avvicinarsi alla famiglia di Marta e in particolar modo alla sorella Luisa e al marito Edoardo, svelando a poco a poco i segreti ormeggiati presso la tragica morte della giovane donna. La morte lascia infatti tutti nell' incomprensione ma ciascuno ha il suo segreto da mantenere, come il marito Edoardo, mascherato da malcelato senso di colpa per ciò che, nella stessa notte della morte della moglie, ha compiuto di efferato. Questa non è solo la storia di una morte, ma è il luogo dell'incantamento di tutti i segreti. Nessuno dei personaggi risulta trasparente e limpido a se stesso: entrano tutti in battaglia, come si allude nel titolo del romanzo, una citazione del dramma Enrico V di Shakespeare, un campo di ombre sfuggenti "avvicinati in modo transitorio da quel qualcuno che li lascia dietro di se". Ciascuno di loro diventa il luogo del peso del morto che erompe dentro il petto finche il morto stesso non avrà pace nè giustizia. È uno stile micidiale quello di Marias, perché serve una penna lucida e tenera, per descrivere il flusso di una coscienza interrotta, rimasta viva a spiegarsi e a perdonarsi la morte, quale è quella di tutti i personaggi del romanzo: la punteggiatura si allontana, i punti fermi non fermano la questione e le virgole non invitano al riposo ma accelerano una scrittura ricorsiva, che fa paio con la ricerca incessante, multiversum, delle ragioni possibili. Vuol dire che Marias apre scenari alternativi e fiordi di possibilità mediante uno stile che si nutre di spirali: ogni affermazione precede il suo gemellaggio con il dubbio o l'idea del diverso. L'affanno del lettore non è solo una questione di occhio che deve seguire il ritmo della penna ma è soprattutto la cifra emotiva di chi sospende la certezza di tutto ciò che sa del mondo e si ritrova a dubitare di ogni parte del cielo. La verità delle cose, infatti, è sempre altrove, alloggia nelle teste di chi resta come semplice miraggio, e il tempo di ciascuno si fa inutile come neve scivolosa. Sfumiamo, dice Marias, tutti verso un lento transitare che sia anche solo su una schiena, una retrospettiva o sul rovescio del tempo. E così, senza scelta, senza altra traiettoria che quella della perdita, perché è assurdo dover ricordare chi si è conosciuto. Potente le ultime parole, un congedo di senso, un riposo del filo: "Addio, Ricordi". L'ultima volta che vale la pena di richiamarli ancora in vita, questi strani, inopportuni e incomprensibili morti.